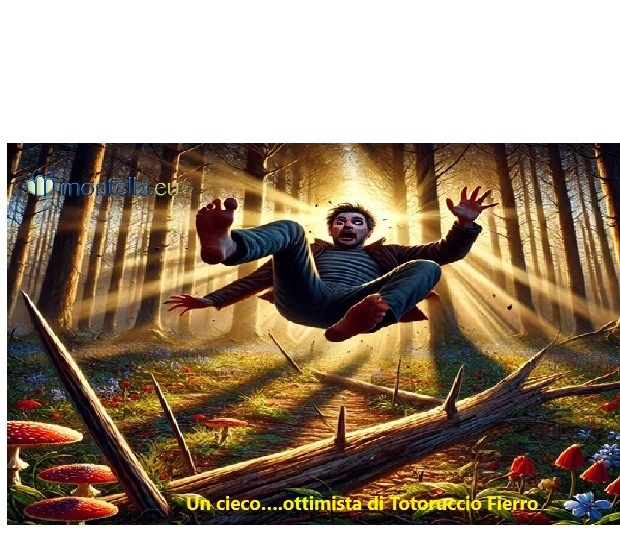A Montella negli anni 1939\40, al tempo della mia infanzia, nella generalità solo poche case erano fornite di un forno per la panificazione.
A Montella negli anni 1939\40, al tempo della mia infanzia, nella generalità solo poche case erano fornite di un forno per la panificazione.
In quegli anni abitavo nel fabbricato di mio nonno Salvatore Ciociola, a due piani, posto prospiciente alla Piazza Sebastiano Bartoli, all'inizio del Corso Umberto e dell’attuale via Don Minzoni.
La casa al piano terra aveva un forno che, fatto a regola d’arte, veniva utilizzato per la cottura del pane che, a quei tempi, veniva per l’appunto “fatto in casa”.
Era questa un’ attività alquanto impegnativa poiché richiedeva perizia, impegno e fatica e ricordo il detto popolare che diceva “ è meno faticoso sgravare un figlio che fare un forno di pane”!
La preparazione del pane non era facile e richiedeva una procedura molto particolare che, innanzitutto iniziava con l’andare a prendere in prestito, per lo più da una parente o da qualche vicina di casa, il cosiddetto “criscito” ossia “il lievito madre” preparato da una precedente infornata e per lo più conservato in un piatto o in una scodella .
Il “criscito”, come tradizione, era stato preparato in una ciotola utilizzando farina e “lievito madre” di un’altra precedente infornata; i due elementi venivano sciolti in acqua tiepida e, una volta amalgamati divenivano “lievito” che lasciato “crescere e fermentare” serviva per preparare l’impasto utile, poi, alla preparazione delle pagnotte di pane.

Parte di questo nuovo impasto era tenuto in serbo, veniva restituito per successive panificazioni.
Ricordo che, a casa mia, ero proprio io ad assolvere all'incombenza di andare a chiedere in prestito il “criscito”; andavo sempre a casa di zia Immacolata, una mia lontanissima parente che abitava nel vicolo Ferri, di fronte alla cantina di zia Carmela.
Una volta avuto in consegna il piatto con il “criscito” mi piaceva, durante il breve tragitto, bucare la crosta e sentire l’odore acidulo tipico di quel preparato.

Altra fase di propedeutica al fare pane era quella della preparazione della farina ottenuta dal grano che, precedentemente conservato nella “canna camera”, era stato macinato di recente in uno dei vari mulini del paese.
La farina dunque, veniva meglio raffinata liberandola dalla crusca e pertanto veniva cernita con un “setino” direttamente nella madia nella quale si preparava l’impasto generale utilizzando farina e “criscito” (vale a dire il cosiddetto “lievito madre”) sciolto in acqua tiepida.

Questo composto, contornato da tutta la restante farina veniva lasciato “crescere” per l’intera nottata e poi l’indomani, di buon’ora, aggiungendo l’acqua tiepida e il sale necessari, si procedeva, sempre nella “martora”, a fare l’impasto amalgamando sia il “criscito” sia tutta la farina cernita in precedenza.
L’impasto veniva lavorato a lungo, con forza, "cazzottando” la pasta, girato e rivoltato continuamente fino a quando in esso non apparivano le bolle che testimoniavano la giusta amalgamazione.

L’impasto globale, coperto con vecchie coperte di lana, veniva lasciato “riposare” per circa due-tre ore per fare in modo che la lievitazione facesse il suo miracolo e la massa praticamente raddoppiasse volumetricamente.
A quel punto la pasta veniva sbozzata, suddivisa in pani che (dalla pezzatura di un chilo e mezzo – due chili) venivano accuratamente sistemati su altre madie o lunghe assi di legno e, con un coltello venivano segnati, generalmente a “croce” e poi anch’essi venivano fatti “riposare”, sempre coperti con teli per far sì che la lievitazione avvenisse in ciascun pane, sia dentro che fuori.
Come mi ha spiegato un’anziana montellese occorreva che la lievitazione proseguisse a temperatura costante giacché, “diversamente il pane non avrebbe avuto alla fine nè una crosta dura e spessa e né la giusta morbidezza all'interno”.
Questa era una fase delicata che richiedeva molta attenzione ed esperienza giacché poteva accadere che la pasta “screscentasse” vale a dire “non crescesse” tanto da compromettere la morbidezza e la sofficità del pane !

Contestualmente a queste fasi di lavorazione, occorreva anche “pensare e preparare” il forno per cui, da un’ora a 50 minuti prima di infornare il pane, si procedeva, di buona lena, a bruciare all'interno del forno stesso fascine, frasche e legna.
Il fuoco dunque avvampava e per il calore i mattoni dell’arcata del forno assumevano, per l’alta temperatura raggiunta (circa i 300 gradi) un colore quasi bianco, “particolare”, incandescente.

A quel punto, utilizzando un rastrello, veniva accuratamente eliminata la brace, spazzata con lo “scopazzo” tutta la cenere, si puliva il fondo con uno straccio bagnato che sfrigolava fuori per ore, e solo a questo punto si infornavano, uno ad uno i pani utilizzando una pala di legno fornita di un lungo stelo.
Dopo l’infornata si procedeva a chiudere la “bocca” principale del forno e poi dalla “bocca d’ispezione (una piccola apertura per l’appunto posta accanto all'apertura centrale) si seguiva il processo di cottura avendo comunque cura di contornare questa seconda apertura con brace e frasche accese.

Quando il pane era cotto e ormai il forno si era quasi raffreddato si procedeva ad estrarre i pezzi di pane e, a trasportalo, ancora ben caldo, in un luogo asciutto dove il pane era messo a raffreddare per far sì che l’umidità fuoriuscisse lentamente e senza creare conseguenze sulla crosta che doveva rimanere fragrante.

Generalmente una volta preparato il pane era possibile conservarlo e consumarlo per circa due settimane prima che divenisse duro e tale da poterlo mangiare solo ammollandolo nell'acqua.
Il pane così preparato era una componente fondamentale dell’alimentazione e, come è noto, costituiva la base dell’alimentazione e del sostentamento infatti tagliato a larghe fette accompagnava ed integrava tutte le fasi del desinare.  Ai tempi della mia infanzia veniva largamente consumato, senza preoccupazioni dietetiche in modo particolare a colazione, inzuppandolo in ciotole di latte e orzo, poi a pranzo ed ancora a cena nonché, per noi ragazzi, essenzialmente a merenda, bagnato con l’acqua e cosparso poi da un filo d’olio d’oliva e da un pizzico di sale.
Ai tempi della mia infanzia veniva largamente consumato, senza preoccupazioni dietetiche in modo particolare a colazione, inzuppandolo in ciotole di latte e orzo, poi a pranzo ed ancora a cena nonché, per noi ragazzi, essenzialmente a merenda, bagnato con l’acqua e cosparso poi da un filo d’olio d’oliva e da un pizzico di sale.
 Con gli stessi ingredienti, vale a dire olio e sale, ma inzuppato nell'acqua di cottura dei fagioli, il pane aveva un sapore unico e particolare così come lo stesso pane, strofinato con la polpa di un pomodoro maturo, cosparso di sale, di un pizzico di origano e da un’abbondante filatura di olio d’oliva costituiva un’altrettanta gioiosa merenda e in qualche caso rappresentava l’unico elemento per il pasto serale.
Con gli stessi ingredienti, vale a dire olio e sale, ma inzuppato nell'acqua di cottura dei fagioli, il pane aveva un sapore unico e particolare così come lo stesso pane, strofinato con la polpa di un pomodoro maturo, cosparso di sale, di un pizzico di origano e da un’abbondante filatura di olio d’oliva costituiva un’altrettanta gioiosa merenda e in qualche caso rappresentava l’unico elemento per il pasto serale.
Anche i “viscuotti”, per mangiarli occorreva inzupparli nell'acqua.
I “viscuotti”, simili alle “gallette del marinaio”, erano simili al pane e potevano essere conservati per periodi più estesi.
Per prepararli si seguiva lo stesso procedimento della panificazione ma, come si evince dal corrispettivo termine italiano, “bis-cotto” erano pani per l’appunto cotti due volte.
 Per fare i “viscuotti” dopo l’impasto i pani venivano allungati come sfilatini, tagliati non a fondo ed infornati similarmente al pane.A mezza cottura, i pezzi (già intaccati ed ancora caldi) venivano definitivamente distaccati, separati singolarmente e rimessi nel forno per una ulteriore cottura al fine, appunto, di “biscottarli”.
Per fare i “viscuotti” dopo l’impasto i pani venivano allungati come sfilatini, tagliati non a fondo ed infornati similarmente al pane.A mezza cottura, i pezzi (già intaccati ed ancora caldi) venivano definitivamente distaccati, separati singolarmente e rimessi nel forno per una ulteriore cottura al fine, appunto, di “biscottarli”.
Ordinariamente il pane e i “viscuotti” veniva fatto in casa a scadenze variabili, rapportate ai consumi e alle abitudini di famiglia.
Non tutte le famiglie avevano la possibilità di preparalo da sé tant’è che, ovviamente anche a Montella vi era l’attività commerciale dei fornai che, come tradizione, preparavano il pane per metterlo in vendita.
 Stando a quanto mi ha riferito un mio e molto più anziano amico “chiazzaiuolo” (cioè cresciuto e pasciuto all'ombra della “teglia” di piazza Bartoli) il primo e più vecchio forno montellese si trovava nel Vico Ferri, in uno stabile che all'epoca apparteneva alla famiglia di “Silao” Cavallo, accanto alla cantina di zia Carmela; era dunque in quello stabile che, negli anni 1915-20, “Peppo” Scandone, aiutato da suo figlio Enrico preparava e vendeva il pane ai montellesi di quell'epoca.
Stando a quanto mi ha riferito un mio e molto più anziano amico “chiazzaiuolo” (cioè cresciuto e pasciuto all'ombra della “teglia” di piazza Bartoli) il primo e più vecchio forno montellese si trovava nel Vico Ferri, in uno stabile che all'epoca apparteneva alla famiglia di “Silao” Cavallo, accanto alla cantina di zia Carmela; era dunque in quello stabile che, negli anni 1915-20, “Peppo” Scandone, aiutato da suo figlio Enrico preparava e vendeva il pane ai montellesi di quell'epoca.
Enrico Scandone non volle continuare l’attività del padre preferendo l’attività di barista e pasticciere e così il forno fu rilevato da Rocco Marano (soprannominato, per il suo carattere mutevole, “lo paccio”) il quale però spostò lo smercio del pane in via Filippo Bonavitacola.
 Inizialmente il negozio era nel palazzo della “vedova Di Benedetto” e successivamente nel palazzo De Stefano; in quel negozio la vendita del pane era fatta da “zia Graziella”, sorella di Rocco, che io ricordo ancora: aveva lunghi capelli, tutti bianchi, raccolti con una acconciatura chignon “a cipolla” (in dialetto montellese a “tuppo”); era una persona dolce, gentile e sempre sorridente; mi sembrava la personificazione di un’anziana fatina.
Inizialmente il negozio era nel palazzo della “vedova Di Benedetto” e successivamente nel palazzo De Stefano; in quel negozio la vendita del pane era fatta da “zia Graziella”, sorella di Rocco, che io ricordo ancora: aveva lunghi capelli, tutti bianchi, raccolti con una acconciatura chignon “a cipolla” (in dialetto montellese a “tuppo”); era una persona dolce, gentile e sempre sorridente; mi sembrava la personificazione di un’anziana fatina.
Successivamente Rocco lasciò il vico Ferri e trasferì il forno presso la sua abitazione, al Vico Santa Maria e dunque la sua attività passò poi al figlio Gerardo che coadiuvato dalla moglie Renata Moscariello mantenne la bottega di vendita sempre in via Filippo Bonavitacola.
 Al tempo della mia infanzia ricordo che in Piazza Bartoli, proprio all'imbocco della via Michelangelo Cianciulli, c’era poi il forno di Cesare Sarni e Immacolata Di Leo ove, con mia sorella Lillina e qualche volta anche da solo, andavo a prendere il pane con “la tessera”.
Al tempo della mia infanzia ricordo che in Piazza Bartoli, proprio all'imbocco della via Michelangelo Cianciulli, c’era poi il forno di Cesare Sarni e Immacolata Di Leo ove, con mia sorella Lillina e qualche volta anche da solo, andavo a prendere il pane con “la tessera”.
Infatti allora, negli anni 1940-44, eravamo al fine della guerra: era un periodo duro, i campi di grano non erano stati arati, né seminati per tempo, la farina scarseggiava e dunque il pane, fatto con non poca crusca, assai “integrale”, veniva razionato, venduto appunto con la “tessera”, un chilogrammo a testa.
Ricordo che Immacolata pesava il pane utilizzando una bilancia, di rame, a bascula che debordava sul bancone fatto di uno spesso marmo bianco; Immacolata era una persona allegra, dalla battuta facile, con me sempre affabile; con la panella da un chilo Immacolata, bonariamente mi tagliava, sempre, un pezzo di “ionta” vale a dire un pezzo di pane aggiunto che io mangiucchiavo e assaporavo durante il tragitto di ritorno a casa.
Forse la mia preferenza attuale per il pane integrale risale, al di là delle argomentazione salutistiche di carattere alimentare, a quell'esperienza lontana.
 Dopo la morte di Immacolta la conduzione del forno passò alla figlia “Iuccia” che, con l’aiuto del marito Pasquale Fierro, lo tenne in funzione fino agli anni 70, vale a dire fino a quando la famiglia “cedette” la licenza e si trasferì nel nord Italia, mi sembra, a Brescia.
Dopo la morte di Immacolta la conduzione del forno passò alla figlia “Iuccia” che, con l’aiuto del marito Pasquale Fierro, lo tenne in funzione fino agli anni 70, vale a dire fino a quando la famiglia “cedette” la licenza e si trasferì nel nord Italia, mi sembra, a Brescia.
Un’altra panetteria di Montella di allora era quella di Antonio Moscariello che oltre a fare il muratore gestiva la vendita del pane coadiuvato dalla moglie Leopoldina e dal figlio Salvatore che continuò l’attività con l’aiuto della moglie, l’intraprendente Maria e cedendola, poi, alla figlia Dina che sperimentò, con poco successo, anche la vendita di pasta fresca, fatta a mano.
Oggi i forni “storici” di Immacolata e di Leopoldina non sono più in esercizio, dei tre forni della mia infanzia l’unico sopravvissuto, come è noto ai montellesi di oggi, è il forno de “la paccia”, è gestito sempre dalla famiglia Marano, è ancora in attività, lo gestisce la giovane Clara e produce un pane che, per i miei gusti, trovo eccellente.
 C’è anche da ricordare che alle “tre storiche panetterie montellesi”, nel trascorrere degli anni, ne sono subentrate altre e precisamente, negli anni 70-80, la panetteria di Buonopane Silvio (che con l’aiuto della moglie Nunziatina Bonavitacola era collocata nelle adiacenze di Piazza Bartoli, in un locale del Palazzo Abiosi); la gestione di questo forno fu poi rilevata da Donato Pellicano, di Acerno il quale, con l’insegna “Panificio Pellicano & Guarino”, ha attualmente forno e panetteria in via Michelangelo Cianciulli.
C’è anche da ricordare che alle “tre storiche panetterie montellesi”, nel trascorrere degli anni, ne sono subentrate altre e precisamente, negli anni 70-80, la panetteria di Buonopane Silvio (che con l’aiuto della moglie Nunziatina Bonavitacola era collocata nelle adiacenze di Piazza Bartoli, in un locale del Palazzo Abiosi); la gestione di questo forno fu poi rilevata da Donato Pellicano, di Acerno il quale, con l’insegna “Panificio Pellicano & Guarino”, ha attualmente forno e panetteria in via Michelangelo Cianciulli.
Un'altra panetteria è oggi in esercizio anche a Sorbo, nell'area dei Mazzei ed è gestita da Rizzo Generoso e suo figlio Toni ma, c’ è da dire anche che, oggi, oltre allo “Spaccio dell’Azienda Agricola Capone” (che a Folloni offre pane e “viscuotti” e prodotti da agriturismo) in tutti gli esercizi alimentari di Montella è in vendita il pane, “forastiero” che proviene da Altamura, Calitri, Montefalcione, Volturara, Parolise, Acerno e non so più da dove ancora !!!
Quel che è certo, è che il pane di una volta aveva consistenza e sapore ben definiti.
Oggi la produzione del pane ha una impostazione industriale, meccanizzata; l'impasto si esegue con macchine (dette impastatrici), per lo più, è cotto in forni elettrici o a gas (di tre tipi: a camere, rotativi e a tunnel), con temperature progressive, con tempi di cottura diversificati (da 13 a 60 minuti) e con incidenze quanto mai contrastanti.
 Da qualche anno sembra che ci sia una riscoperta del piacere di fare il pane in casa, tant'è che in molte case oggi è in uso la “macchina per il pane”, una impastatrice automatica che oltre ad impastare il pane lo lascia anche lievitare e lo cuoce, mantenendolo poi in caldo prima dell’uso.
Da qualche anno sembra che ci sia una riscoperta del piacere di fare il pane in casa, tant'è che in molte case oggi è in uso la “macchina per il pane”, una impastatrice automatica che oltre ad impastare il pane lo lascia anche lievitare e lo cuoce, mantenendolo poi in caldo prima dell’uso.
Un sistema questo efficace nella lavorazione, decisamente salutare, meno stancante ed assolutamente molto più semplice rispetto allo ….…” sgravare un figlio” !
Capita anche che, a Montella e in tante altre comunità, si è saggiamente riscoperta la vecchia tradizione del pane comune, quello di un volta, utilizzando dunque farina, levitazione e cottura tradizionali.
Si ritrova dunque un pane saporoso, fragrante ma è pur sempre un pane assolutamente diverso da quello della mia infanzia, un pane quello, unico e che per me è tale perché, ne sono certo, lo assaporavo e gustavo con ……un companatico particolare, quello della giovinezza e della spensieratezza di giorni, ahimè, troppo lontani.
 Il presente articolo è stato già pubblicato nel settembre 2016 nel periodico "Il Monte" dell’Arciconfraternita del SS Sacramento di Montella, nella sezione "Irpinia Magica".
Il presente articolo è stato già pubblicato nel settembre 2016 nel periodico "Il Monte" dell’Arciconfraternita del SS Sacramento di Montella, nella sezione "Irpinia Magica".